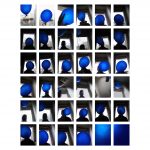Testo e Fotografie di Maria Teresa Carbone
Mentre comincio a scrivere questo testo, arriva la newsletter di Frieze: al Sundance Film Festival è stato presentato il primo lungometraggio dell’artista ispano-argentina Amalia Ulman, El Planeta, in cui la regista e sua madre Alejandra interpretano un doppio ruolo: se stesse e due donne che a Gijón, la loro città, sono riuscite a raccogliere cinquemila euro in vestiti e cibo solo perché davano l’impressione di essere ricche. Una sorta di make believe al cubo.
Intanto nella mia casella spam si sono depositati quattro messaggi che mi proclamano fortunata vincitrice di incredibili somme di denaro. Incredibili, appunto. Eppure ho letto che tra il 2016 e il 2019 truffe via mail sempre più sofisticate sono costate ai clienti circa 26 miliardi di dollari.
E tra la posta recente un’amica mi segnala il progetto Being Alone Together: Developing Fake News Immunity realizzato da Elena Musi dell’università di Liverpool “per consentire ai cittadini di confrontarsi in modo critico con le informazioni manipolate che trovano in rete, in particolare durante la pandemia da Covid-19”. Il progetto prende la forma di un gioco (se si preferisce, è un esempio di gamification) e consiste in un chatbot, una conversazione simulata con Socrate, Aristotele e Gorgia: sono loro a spiegarci come possiamo sviluppare l’immunità contro le fake news.
Già, fake. Una parola di uso comune, ormai. Un segno del nostro tempo. Ma è davvero così? In realtà di notizie false spacciate per vere è disseminata la storia umana, e probabilmente anche la preistoria, se solo avessimo accesso a quello che è accaduto prima che la scrittura rendesse durature le verità come le bugie – le quali, a dispetto di un vecchio proverbio caduto in disuso come tutti i proverbi, non hanno le gambe corte, e anzi viaggiano, viaggiano nel tempo e nello spazio.
Si è fondato per secoli su un falso, la Donazione di Costantino, il potere temporale dei papi. E hanno precedenti antichi le teorie del complotto che oggi individuano in Bill Gates e nel 5G i responsabili della pandemia. Come agenti di cospirazioni mondiali sono stati additati di volta in volta i gesuiti, i massoni, gli ebrei, se non vogliamo tornare più indietro nel tempo, al grande incendio di Roma del 64 d.C., in cui vorticarono accuse e controaccuse che non risparmiarono praticamente nessuno.
E tuttavia oggi la diffusione del fake ha tratti specifici che non possono ricondursi solo alla “naturale” tendenza umana a trovare credibili soprattutto (o unicamente) le affermazioni che ci confermano quello che già pensiamo. C’è in primo luogo una questione di quantità: non solo siamo in tanti, più di quanti siamo mai stati, ma aumenta di continuo la massa di informazioni a nostra disposizione, e – altro elemento distintivo del presente – abbiamo connessioni che ci permettono di stabilire contatti da un capo all’altro del pianeta in un tempo misurabile in secondi.
Avere la possibilità reale di collegare istantaneamente tra loro oltre sette miliardi di persone è una novità assoluta, che porta con sé una diffusione potenziale delle notizie – vere o false che siano – del tutto inedita. Non solo: questa enorme quantità di informazioni è spesso veicolata attraverso immagini (fotografie o brevi video) ed è dunque facilmente accessibile anche a chi ha poca o nulla dimestichezza con la lingua scritta.
I sei gradi di separazione che secondo la teoria del mondo piccolo si frappongono fra un umano e l’altro sembrano oggi molto più corti di un tempo. E la tecnologia che virtualmente ci avvicina, ci
consente di manipolare testi, immagini, video e audio con una raffinatezza estrema, tale da rendere l’inganno impercepibile. La demarcazione fra il vero e il falso – o fra fatto e finzione – appare sempre più sfumata. In un contesto culturale che giustamente tutela la libertà di espressione e favorisce l’autodeterminazione individuale, le affermazioni dei terrapiattisti possono farci sorridere, ma sono la reazione esasperata (e sicuramente ridicola) di chi sentendosi sopraffatto finisce per ritenersi vittima di un gigantesco inganno.
Fare informazione in modo critico non è facile. Gli ostacoli sono molti: il ritmo incalzante del flusso di comunicazione, il ruolo ambiguo dei social network, fonte primaria o unica di informazioni per moltissimi, i tagli di cui i media sono stati oggetto negli ultimi venti o trent’anni (redazioni ridotte ai minimi termini, trattamenti economici irrispettosi, scomparsa progressiva o radicale trasformazione di diverse figure professionali, dai corrispondenti dall’estero ai critici letterari, cinematografici, teatrali…).
Eppure, come per fortuna succede spesso nei momenti di crisi, ci sono segnali di movimento: continuano il loro declino i giornali tradizionali, ma si moltiplicano nuove testate che sperimentano forme diverse per rivolgersi al pubblico, dai podcast alle newsletter – tentativi spesso individuali di fornire un’informazione accurata e svincolata dall’agenda dominante. Forse non è molto, rispetto al potere degli algoritmi che tendono a richiuderci in un mondo dove vivono solo i nostri simili, quelli che la vedono come noi, quelli – soprattutto – che comprano le nostre stesse cose. Ma la buona riuscita di esperienze come Valigia blu o di Guerre di rete lascia pensare che non solo ci sono giornalisti ancora capaci e desiderosi di fare bene il loro mestiere, ma anche lettori pronti a sostenerli. E questa è davvero una buona notizia.