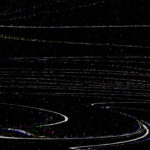di Artemisia Liveriero Lavelli
John Cage quando presenta l’opera 4’33’’ porta in concerto l’assenza di musica, dimostrando che un silenzio assoluto non può esistere, dal momento che in una sala si confonderebbe ai rumori del pubblico, del traffico all’esterno, a fruscii e bisbigli; persino in una stanza insonorizzata si riuscirebbe a sentire il proprio battito cardiaco o un vociare indistinto nella testa.
Cage, con i suoi studi, arriva a considerare addirittura il silenzio come un “rumore di sottofondo”.
Per meglio intenderci possiamo ragionare sul silenzio e sulla voce su due piani interpretativi, quello fisico e quello mentale, metaforico.
Iniziamo considerando il silenzio fisico: questa (quasi) assenza di suono ci permette di acuire gli altri sensi; quando guidiamo, per esempio, abbassiamo il volume della radio per vedere meglio – del resto percepiamo in modo sinestetico: ascoltiamo i colori, tocchiamo la musica.
Il suono, il rumore può essere destabilizzante sia a livello psichico che somatico; ce lo ricorda Alberto
Tadiello nel suo ciclo di tre opere sulle armi sonore: una è l’installazione 25L che si trova alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e rappresenta una tromba, un fiore pericoloso di tubi e vibrazioni tossiche, che venendo azionato ci disturba (anche se minimamente rispetto alle vere Sonic Weapons, usate per esempio nella guerra in Iraq, o durante le proteste no global al summit del G20 nel 2009 in cui la polizia di Pittsburgh impiegò il Sonic Cannon per disperdere i manifestanti).

La voce e il suono possono essere analizzati e quantificati in termini minimi, in battiti: sul piano fisico la voce è caratterizzata da timbro, intonazioni, pause, mentre su quello linguistico consideriamo la conversazione come un insieme di discorsi, che possiamo scindere in frasi, fatte di parole, composte da fonemi. Percepiamo sia la voce (rumore esterno) che il pensiero (rumore interno) in una dimensione cronologica, consequenziale. Il linguaggio, infatti, si fonda sulla causalità, sul poi che dipende dal prima, sul rapporto causa-effetto. Noi esseri umani, nascendo già nel linguaggio, viviamo questa concezione anche nel pensiero logico-razionale. Questa concezione di un tempo lineare viene espressa anche nella dottrina cristiana che ricerca una salvezza nel futuro come espiazione del peccato del presente.
Considerando il silenzio nella sua accezione più metaforica, mi collego a molte pratiche meditative che si basano sulla ripetizione di un mantra o sull’attenzione al respiro proprio con l’idea di placare la mente, di riequilibrare la sensazione di transitorietà di un presente che sfugge. Marie-Louise von Franz, sulla linea di pensiero di Mircea Eliade, in Psiche e Materia (1988) sostiene che lo yogi “mediante esercitazioni respiratorie cerca di superare il tempo abituale e sciogliere tutte le catene cosmiche. Allora respira all’unisono col grande tempo cosmico.”
Il silenzio come spazio mentale ci fa affacciare in modo più profondo a questa eternità del tempo presente, diversamente dalla voce, dal rumore, dal vociare indistinto e mutevole che si scioglie nell’istante in cui si presenta, sovrastandosi continuamente come nel tempo lineare rappresentato dal dio Chronos, che divorava i suoi figli perché questi l’avrebbero inesorabilmente spodestato.
La totalità del tempo intesa ciclicamente, la fusione di attimi inscindibili che attingono dall’eternità in un presente senza estensione viene assimilata al tempo Aion (in greco “forza vitale”, “durata”, “eternità”) che è immobile e immutabile.
Roland Barthes sostiene che in ogni fotografia ci sia una co-presenza di ciò che è rappresentato nello scatto (i soggetti, l’ambiente) che chiama studium e un “particolare” pungente, il punctum, che invece ci colpisce, ci ferisce quasi, nel porci di fronte a una verità assoluta che sta oltre l’aspetto visibile. Barthes nel suo libro La camera chiara (1980) ci racconta di aver trovato poco dopo la morte della madre una fotografia che la ritraeva, all’età di cinque anni, col fratello: “Osservai la bambina e finalmente ritrovai mia madre. La luminosità del suo viso, la posizione ingenua delle sue mani, il posto che essa aveva docilmente occupato senza mostrarsi e senza nascondersi […]”.
In quella foto il punctum ha svelato la verità del volto della madre che l’autore stava cercando.
Nel libro, lo studioso non riporta lo scatto di cui sta parlando, probabilmente perché quel che lo ha colpito è prettamente soggettivo e non toccherebbe particolarmente noi.
Io credo di aver riconosciuto una sensazione analoga a quella provata da Barthes in un mio scatto che raffigura una bambina al centro, che silenziosa ma con ancora l’ombra di un sorriso, guarda altrove. Mi sembra sospesa quasi in un tempo eterno e indefinito, diversa dalla folla vociante che la circonda, su cui il nostro sguardo vaga attratto, ma soprattutto distratto prima da uno sguardo, poi da un movimento.
Mostrando questa foto alcuni hanno creduto fossi io da bambina, o mi hanno provocatoriamente chiesto se fosse un’autorappresentazione.
Forse mi ha attirato poter percepire in lei uno spazio di silenzio, espressione di un tempo che si estende a un passato e a un futuro nel presente, come quello dell’attimo pregnante di cui ci parla Gotthold Ephraim Lessing e che ritroviamo per esempio in Leonida alle Termopili, di Jacques-Louis David, ma anche in molti dipinti di Caravaggio (come Matteo e l’angelo) e nelle sculture di Canova.
Forse la bambina per me è la manifestazione del bisogno di un tempo altro, che non scorre senza essere goduto.
Talvolta, nelle nostre esistenze distratte – rivolte costantemente o a un futuro incerto o alla memoria del passato, nella nostra abitudine a quantificare il tempo in ore di lavoro o in denaro – troviamo il bisogno di fermarci, di allontanarci dal tempo cronologico che ci sfugge dalle mani e lasciarci immergere nel silenzio, così da estraniarci, almeno momentaneamente, dal caos della voce già muta nell’attimo del suo affiorare.