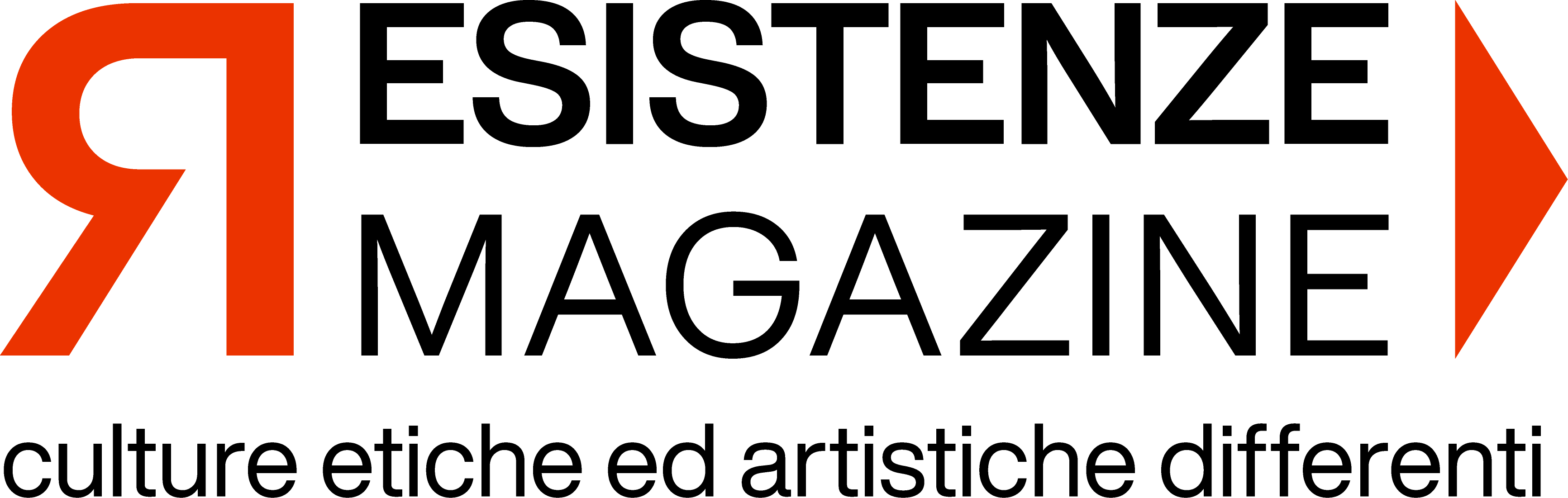di Ave Appiano
Riprendendo il principio espresso da Vitruvio nel terzo libro del trattato De Architectura (I sec. a.C.), la base dell’ars aedificatoria è la commistione di tre principi, la firmitas (la solidità costruttiva), l’utilitas (la destinazione d’uso) e la venustas (la bellezza). Oltre ai principi strutturali e di funzione, che costituiscono il fondamento dell’opera ovvero l’ergon, e anche oltre il fascino della seduzione, si colloca l’Ornamento come supplemento aggiuntivo e complementare. Il carattere additivo dell’ornamento, nell’incorporare dati ausiliari all’oggetto, lo sposta dal naturale all’artificiale. Manifestandosi oltre l’essenza esso diventa oggetto filosofico, e in quanto accessorio denuncia un’insufficienza dell’ergon. Immanuel Kant, nella Critica del Giudizio (Analitica del Bello, par. 14) ascrive gli ornamenti, i fregi, alla categoria dei parergon, cioè a quelle cose che non appartengono come parte costitutiva all’oggetto ma “soltanto come accessori esteriori”. E su questa linea Jacques Derrida, commentando Kant, definisce il parergon come qualcosa che sta “in posizione subordinata e in più dell’ergon”, dell’opera, “non si trova a lato” ma “si riferisce e coopera” oltre eppur all’interno dell’insieme.
Poiché l’ornamento assegna carattere all’opera, esso è portatore di Verità nell’allestimento e nella realizzazione del Bello, similmente a quanto accade in chiave retorica. La necessità dell’ornamento
è ciò che corrisponde infatti, nell’arte oratoria, a rinforzare un concetto ovvero al principio di Epiphorà, ossia al portare in aggiunta, per ottenere una Condita oratio, un conditus sermo, un abbellimento del discorso (una Oratio infatti è “inornata” quando è scarna).
Il capitello corinzio, ovvero l’artificio dell’ornamento
Tra teoria delle Idee e creazione artistica, il capitello corinzio rappresenta, oltre la mera imitazione e interpretazione della natura, quel prototipo di bellezza fondata sull’artificio come integrazione d’anima. Ancora Vitruvio (De architectura, libro IV), riferisce di come l’idea del capitello corinzio ebbe origini leggendarie dall’ispirazione che l’architetto scultore e pittore greco Callimaco (V sec. a. C.) ebbe di fronte a un cesto ricoperto da una pianta di acanto su una lastra votiva sepolcrale di una fanciulla. L’idea, che per Vitruvio è la forma della dispositio, ossia della raccolta e composizione degli elementi (le foglie e gli steli ricurvi), risponde a un modello interiore di ordine, in cui trovano posto i prodotti dell’immaginazione che lì si trasformano in una dimensione intellettuale. Il capitello corinzio, ottenuto con arte sul principio di perfezione, contrapposto al modello naturale di uno spontaneo cespuglio di foglie dentellate, documenta come l’ornamento riesca ad allestire e veicolare, per gradi di astrazione, l’assoluto naturale custode di verità. Esso sintetizza l’essenza della poiesis dell’arte e il principio di bellezza. L’idea estrae il soggetto dalla natura e trasferendolo in pietra o marmo lo rende eterno, le foglie perdono la loro disordinata naturalità traducendosi in una composizione geometrica ordinata con gli steli simmetrici avvolti in piccole volute uscenti dal fogliame. Dall’oggetto reale all’ornamento, il capitello corinzio greco assume poi connotazioni ancora più marcate in quello composito romano che risulta essere la combinatoria dei due ordini distinti ionico e corinzio. La “grazia esibita” dell’ordine corinzio, il voluttuoso abbellimento di transito dal naturale all’artificiale ed espressione di quell’ars aedificatoria che dal mondo ellenistico passa a quello romano, segna la convergenza fra l’eidos e l’eidolon, ossia tra l’Idea platonica – o la Forma aristotelica – e la sua conversione in immagine. L’inventio, che nella retorica corrisponde all’individuazione di “topoi codificati”, esprime nel capitello corinzio il momento ideativo del “vedere oltre”, l’attimo in cui l’immagine, dalla sua inconsistenza universale, si condensa e oggettivizza nella mente del creatore. Non imitatio naturae, non mimesis artistica, dunque, poiché questa, aderendo alla realtà si sarebbe allontanata dall’Idea.
L’idea è allora il risultato di un’intuizione e di una trasformazione dalla natura all’immaginazione attraverso l’artificio. Il capitello corinzio del Tempio di Vesta a Tivoli, di derivazione dal modello greco, valorizzato nel ‘500 da Sebastiano Serlio e Andrea Palladio nei loro Trattati sull’Architettura quale inno all’ornato estetico, fu fonte di ispirazione nell’abbellimento dell’architettura barocca e neoclassica come sigla di grazia equilibrata ed esibita, di bellezza ideale, sorprendente e armonica. Riprodotto nelle incisioni di Giovanni Battista Piranesi nel ‘700, divenne soggetto pittorico per numerosi artisti romantici che ne seppero valorizzare il tratto identificativo trasferendo il carattere additivo d’ornamento dall’oggettività tridimensionale alla sua visualizzazione bidimensionale, secondo una doppia logica di interpretazione della natura. Ponendosi dunque, l’artificio, come supplemento all’oggetto, esso assume il ruolo di strumento dell’arte, nel suo intermedio rapporto con la filosofia e con la ricerca della verità attraverso la bellezza.