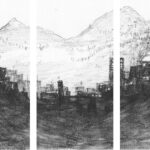Il suono delle/nelle immagini
di Bruno Di Marino
“Il cinema sonoro ha inventato il silenzio”. Si potrebbe partire da questa straordinaria definizione di Robert Bresson per esplorare l’importanza del suono (ma anche della sua assenza) nella dimensione visuale. E non parliamo solo delle immagini in movimento, dove la parte sonora è connessa in modo automatico e naturale a ciò che vediamo (i suoni ambientali), ma anche delle immagini fisse: dovremmo domandarci se in alcuni quadri o in alcune fotografie prevale il silenzio o il suo contrario, fino al “rumore”, inteso anche nel suo significato entropico-comunicazionale. E poi, naturalmente, esistono anche film in cui la mancanza di colonna sonora è una scelta ben precisa. Pensiamo al cinema sperimentale che, in diverse occasioni, vi rinuncia del tutto: la maggior parte delle centinaia di film di Stan Brakhage è senza suono, così come silent sono i primi film realizzati da Andy Warhol. Uno sperimentatore italiano come Paolo Gioli preferisce ad esempio definire i suoi cortometraggi in 16mm “silenziosi” piuttosto che “muti”. Non è solo un vezzo lessicale, ma in questa precisazione c’è anche un grande scarto concettuale. Del resto John Cage nel suo celebre brano 4’33” ci ha dimostrato come si possa comporre musica senza suono, esaltando i vuoti anziché i pieni, il levare anziché il battere. Il rapporto tra i suoni e le immagini ci offre una vasta gamma di possibilità cui vale la pena almeno accennare. Potenzialità che, soprattutto con l’evoluzione delle forme audiovisive, si sono moltiplicate. Ci sono registi che usano i dialoghi, i suoni e la musica al minimo, e allora il silenzio diventa un elemento denso, che ha un suo peso specifico, che diventa protagonista. Se dovessi nominare un film non avrei dubbi: Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, Bruxelles, il capolavoro di Chantal Ackerman. Ma poi esistono anche film in cui il silenzio si accompagna allo svuotamento di campo, alla sospensione: il cinema di Ozu in questo senso è esemplare; con le vedute della casa vuota, che ci viene mostrata nella sua autonoma esistenza rispetto alla presenza e alla vita dei personaggi. Il vuoto, del resto, è un concetto tutto orientale che un cineasta giapponese comprende bene. E il silenzio domina anche in tanti film di Mizoguchi. Ma le cesure, gli svuotamenti, i silenzi, possiamo trovarli ovunque, in qualsiasi film di qualunque regista. Possiamo provare a metterli insieme, a legarli tra loro. E’ quanto hanno fatto Muller e Girardet in Phoenix Tapes (1999), omaggio al cinema di Hitchcock realizzato nel centenario della sua nascita. Nella prima parte del film, soprattutto, quest’opera di found footage assembla tutti i momenti in cui il cinema del maestro inglese interrompe l’azione oppure i campi lunghi che servono da raccordo. Rimettendo insieme i vari pezzi ne risulta un film di Hitchcock totalmente diverso da quello che ci saremmo attesi. Ma d’altronde c’è un cinema tra le righe, negli interstizi. E in queste visioni risuona spesso il silenzio. E nella fotografia? Nella pittura? E’ azzardato forse dire che un paesaggio è sempre silenzioso e una scena di battaglia sempre rumorosa? E un ritratto, invece? E’ dominato dal silenzio o dalle parole e dai suoni? Quando guardo una delle fotografie di Robert Capa dello sbarco in Normandia sento il fischio delle pallottole? Roland Barthes ne La camera chiara non ci parla del suono nella fotografia in modo esplicito, ma ci parla del “fuori campo”. E ciò che non vediamo nell’immagine possiamo evocarlo sotto forma di suoni. Suoni di cui non vediamo la fonte, suoni acusmatici per usare una definizione di Michel Chion. E non c’è forse film più potente in questo senso de Il figlio di Saul di Laszlo Nemes, dove dell’orrore dei campi nazisti ascoltiamo solo i suoni strazianti che provengono dai bordi dell’inquadratura, perché per tutta la durata la macchina da presa ci mostra quasi solo il volto o la nuca del protagonista. Il dipinto più sonoro? Una delle versioni della Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, anch’esso fondato su un fuori campo (o fuori quadro): dopo aver decapitato Oloferne, Giuditta e la sua ancella guardano timorose verso destra, probabilmente perché hanno udito il rumore dei soldati che si trovano fuori dalla tenda del generale. Il silenzio, in molti casi, può essere assordante. Lo è quando diventa il motore di una drammaturgia che si volge dentro e fuori l’immagine e ne cambia totalmente il senso.

Immagine in evidenza: Artemisia Gentileschi, Giuditta e la fantesca dopo la decapitazione di Oloferne, 1615 ca.